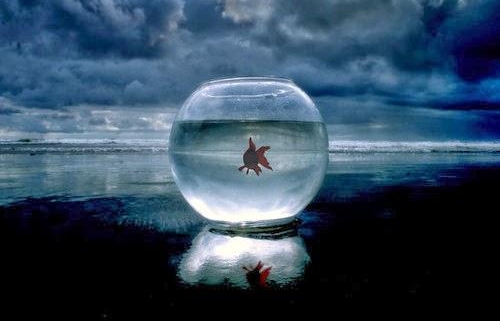Quando una PARTITA di CALCIO NON è SOLO una PARTITA di CALCIO: fra casualità, coincidenze, sincronicità e sequenze di Fibonacci
Jung la chiamava sincronicità, l’idea secondo la quale ciò che accade, nella nostra vita, ha un significato preciso e una ragione. Detta in altri termini: nulla accade per caso. Purtroppo però, non sempre è facile capire il significato degli eventi e dare loro un senso. Come ciò che è accaduto qualche giorno fa…
Nel week end appena trascorso, il Liverpool ha conquistato il secondo titolo di Premier League ma ha non solo vinto, ha anche
completato l’apertura di una serie eccezionale di numeri.
Sequenza che emerge quando classifichiamo il Liverpool insieme agli altri club che hanno vinto la Premier League dalla sua fondazione nel 1992, partendo dal più basso.
Blackburn Rovers: 1
Leicester City: 1
Liverpool: 2
Arsenal: 3
Chelsea: 5
Manchester City: 8
Manchester United: 13
Ossia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
Sequenza che potrebbe sembrare, per i più, poco o per nulla significativa. Ma non per gli appassionati di matematica che la riconosceranno come la successione di Fibonacci, in cui ogni numero (dopo i primi due) è la somma dei due precedenti nella sequenza.
LA SEQUENZA DI FIBONACCI
Questa sequenza può essere riscontrata in una sorprendente varietà di contesti: arte, botanica, architettura, solo per citarne alcuni. In molti fiori, per esempio, il numero di petali rispecchia la sequenza di Fibonacci: gigli e iris hanno 3 petali, primula e rosa canina 5, cosmea 8.
Le sequenze di Fibonacci furono introdotte per la prima volta nella scienza europea nel 1202 da Leonardo da Pisa, noto anche come Fibonacci.
Tuttavia, molto prima che Fibonacci rendesse popolari le sequenze, queste erano già note ai matematici indiani che vi ricorrevano per aiutarsi a enumerare il numero di possibili poesie di una data lunghezza, usando sillabe brevi di una unità di durata e sillabe lunghe di due unità di durata. Capirono cioè che per calcolare il numero di poesie di una data lunghezza bastava aggiungere il numero di poesie che erano più corte di una sillaba al numero di quelle che erano più corte di due sillabe – la stessa regola esatta che usiamo oggi per definire una sequenza di Fibonacci.
Nascosto nelle sequenze si cela un altro importante pilastro matematico: la sezione aurea. Man mano che i termini di una sequenza di Fibonacci aumentano, il rapporto tra ciascun termine e quello precedente si avvicina sempre di più alla sezione aurea, approssimata a 1,61803 dalle prime cifre della sua espansione decimale. Si ipotizza che la sezione aurea governi la disposizione delle foglie sullo stelo di alcune specie vegetali e presumibilmente porti a risultati esteticamente gradevoli quando applicata in arte, architettura e musica .
COINCIDENZE O SCIENZA?
Le sequenze di Fibonacci sono spesso considerate esempi della bellezza della matematica, capaci di fornire vividi esempi visivi di matematica insita negli schemi del mondo reale, senza i quali si farebbe fatica a comprendere. Eccessivo entusiasmo può però portare a considerare le sequenze di Fibonacci, la sezione aurea o anche solo eventi di sincronicità come una sorta di legge naturale onnicomprensiva che governa fenomeni di ordini di grandezza diversi, dalle forme a spirale delle conchiglie, ai vortici degli uragani fino alle galassie.
In realtà, sebbene queste caratteristiche naturali siano esteticamente gradevoli, pochissime di esse rispettano le regole della sequenza di Fibonacci o presentano la sezione aurea.
CALCIO, SEQUENZE O CASUALITA’
È straordinario ad ogni modo scoprire la sequenza di Fibonacci in un luogo così inaspettato come il calcio. Che ci sia un processo sorprendente e invisibile alla base delle lotte per il titolo della Premier League o è solo una curiosa coincidenza?
Solo perché possiamo vedere una sequenza di Fibonacci in qualcosa non significa che sia lì per un motivo.
Tuttavia, individuare questo tipo di apparenti coincidenze può essere estremamente utile per il processo di scoperta scientifica. Nel 1912, Alfred Wegener notò che la costa dell’Africa occidentale e quella orientale del Sud America sembravano incastrarsi come pezzi di un puzzle. Nonostante l’opinione prevalente all’epoca, secondo cui le enormi masse continentali fossero semplicemente troppo grandi per essere spostate, Wegener propose l’unica teoria che conciliasse le sue osservazioni. La deriva dei continenti suggeriva che le masse continentali non fossero radicate in un luogo ma potessero, molto lentamente, cambiare la loro posizione relativa sulla superficie terrestre.
Forse, oggi, siamo solo incapaci di dare un senso… anche se (o proprio perché) si tratta solo di calcio… e lo scrive una che di football sa ben poco. A ognuno la propria interpretazione!