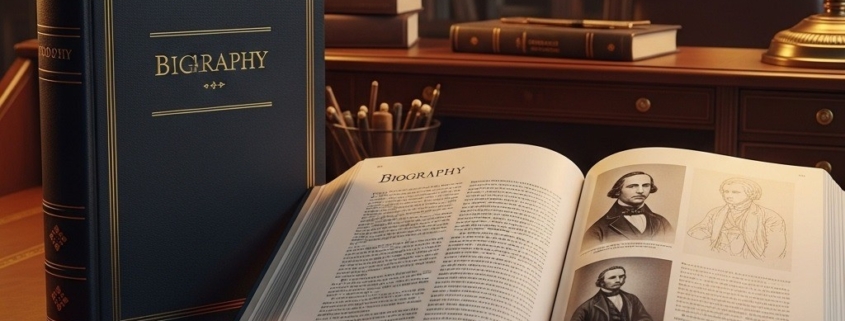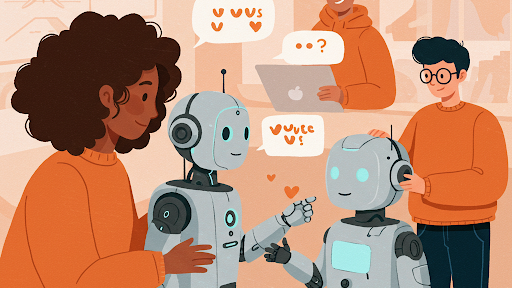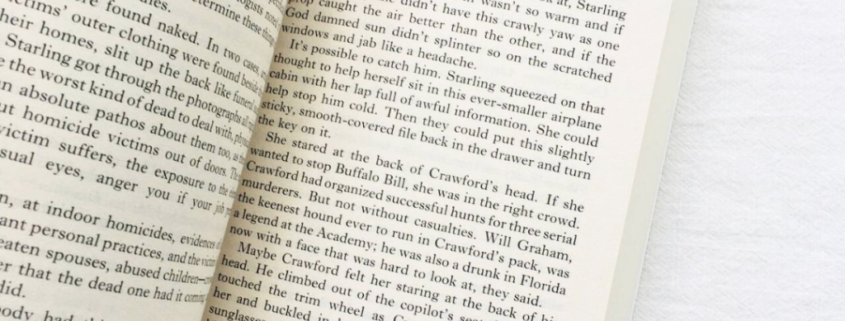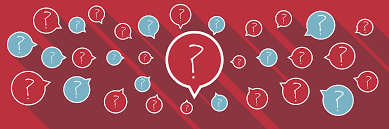Nelle ultime settimane, ho avuto molto a che fare con persone con tendenze passivo-aggressive. È stato naturalmente stancante e poco edificante, anche (solo) da consulente. Insidiosi e manipolatori, spesso vengono identificati e intercettati troppo tardi, a danno fatto o quasi. Conoscere caratteristiche e motivazioni, può fare, talvolta, la differenza!
COSA SI INTENDE PER COMPORTAMENTO PASSIVO-AGGRESSIVO
Il comportamento passivo-aggressivo venne identificato dal colonnello William Menniger nel corso della II guerra mondiale[1]. Egli isolò alcuni particolari comportamenti da parte dei suoi soldati differenti dai soliti ribelli, ma in egual modo aggressivi e disfunzionali. Tali comportamenti si palesavano mediante misure passive come una spiccata caparbietà, temporeggiamento, broncio e sabotaggio passivo dei loro doveri militari.
Se vogliamo darne una definizione:
Il comportamento passivo-aggressivo è un modo deliberato e mascherato di esprimere sentimenti di rabbia[2].
Deriva dall’incapacità dell’individuo di esprimere e canalizzare le emozioni verso un’espressione assertiva, quest’ultima “sostituita da un’eccelsa mistificazione delle emozioni mediante l’immagine di una persona carismatica, ironica e da una forte personalità. Questo modus operandi conduce il passivo-aggressivo ad agire mediante una sorta di non azione, motivata da emozioni e motivazioni negative e una forte ostilità”[3].
Ognuno di noi può assumere atteggiamenti di tipo passivo-aggressivi. Il problema nasce nel momento in cui queste modalità diventano le uniche modalità di interazione.
ESEMPI
Manager: “Ho notato che siamo un po’ in ritardo per la presentazione. La scadenza del cliente si avvicina e dobbiamo rimetterci in carreggiata. Tutto bene? Hai bisogno di aiuto o risorse per rispettare la scadenza?“
Collaboratore (in modo passivo-aggressivo): “Oh, certo. È semplicemente fantastico che tu abbia notato che la scadenza si avvicina. Sto solo lavorando giorno e notte a questo progetto. Ho poteri sovrumani, giusto? Certo, posso fare tutto da solo. Non c’è bisogno di preoccuparsi“.
Un altro esempio comune sul posto di lavoro è quando si esprime disgusto in modo sottile, con frasi come: “Come da mia ultima e-mail”, “Non sono arrabbiato con te”, “Qualsiasi cosa ti occorra ti aiuto io”, “Stavo semplicemente scherzando”, “Io pensavo che tu fossi a conoscenza di…”, quando, in realtà, il comportamento adottato intende esprimere esattamente il contrario…
Anche quando si chiede a un amico di essere accompagnati da qualche parte e seppur questo risponda: “Sì, mi piacerebbe molto“, poi arriva in ritardo lamentandosi: questa è aggressività passiva.
CARTA DI IDENTITA’ DEL PASSIVO AGGRESSIVO
COMMENTI SARCASTICI. Una persona passivo-aggressiva potrebbe usare commenti sarcastici per sminuire chi le sta intorno o per far sembrare meno gravi le osservazioni taglienti che ha appena condiviso.
La gravità del sarcasmo dipende dal contesto e dal rapporto con l’interlocutore. Quando l’obiettivo è aggiungere umorismo alla conversazione, alcuni potrebbero persino apprezzarlo. Ma è fondamentale non usare l’umorismo per ferire.
CRITICA INDIRETTA. Le critiche costruttive sono utili ma possono essere dolorose e spietate quando vengono fatte per ferire e umiliare. Un collega potrebbe criticare indirettamente con tono condiscendente. Se non credesse nella tua capacità di completare bene un compito, potrebbe dire: “Sei sicuro di poterlo fare?” o “Se è troppo difficile da fare da solo, fammelo sapere“.
In altri casi, la critica potrebbe essere più diretta. Se al collega non piacesse il modo in cui stai portando avanti un progetto, potrebbe dire: “È un modo strano di farlo” o “Sei terribilmente concentrato su [aspetto del progetto]”.
SILENZIO. Il silenzio viene usato per esprimere disapprovazione. In una relazione personale, un esempio potrebbe essere una persona che si rifiuta di parlarti dopo che hai chiesto di “stare da solo”. Invece di avere una conversazione sul perché potrebbe essersi sentita ferita, si allontana per dispetto[4].
RISENTIMENTO DELLE ISTRUZIONI. Le persone passivo-aggressive potrebbero risentirsi o opporsi alle istruzioni e indicazioni, anche se continuano a fare ciò che viene loro detto. Potrebbero diventare polemiche con la persona che delega o irritabili mentre lavorano.
SABOTARE COMMETTENDO ERRORI. Sabotare le attività è un modo in cui le persone passivo-aggressive possono esprimere infelicità o frustrazione. Possono protestare contro le richieste degli altri, procrastinando o commettendo errori intenzionali per evitare di ricevere un compito simile in futuro. Un collaboratore può ritardare il completamento di un progetto o inviarlo con errori evidenti ma sottili.
FARE COMPLIMENTI INDIRETTI. I complimenti indiretti spesso suonano genuini, ma hanno un sottile tono insultante o suggeriscono un difetto. Una persona passivo-aggressiva potrebbe ricorrervi per evidenziare una qualità che possiedi o sminuire il tuo lavoro su un progetto o un compito.
Un complimento indiretto potrebbe essere: “Mi piace quanto sei accomodante quando prendi decisioni“. In questo caso, la parola “accomodante” potrebbe suggerire che pensa che tu non prenda decisioni in modo efficace da solo. Oppure: “Hai lavorato così tanto per ottenere quell’incarico“, suggerendo che hai provato ma non ci sei riuscito.
TRATTI DISTINITIVI
Sono egoisti. Una persona passivo-aggressiva è alla continua ricerca di approvazione. Quando completa le attività, non pensa tanto al risultato o all’organizzazione quanto a come viene percepita. Nel tempo, infatti può essere considerata altamente competitiva e orientata ai risultati. Ma uno sguardo più attento rivela che il fine ultimo è il proprio interesse personale, non il bene comune.
Vogliono la fedeltà degli altri. Essere un collaboratore o parte della squadra non è di interesse per un passivo-aggressivo, soprattutto se non gli è utile. Piuttosto che mostrare fedeltà, vuole ottenerla dagli altri.
Si preoccupano di cose che non li riguardano. Poiché è così concentrato su ciò che fanno gli altri e su come ciò influisce sulle dinamiche di potere in ufficio, spesso non si concentra sul suo lavoro.
Il passivo-aggressivo è molto preoccupato per le cose che sono al di fuori della sua portata, poiché si ritiene che queste cose possano potenzialmente influenzarlo in modo negativo in futuro. Anche se sembrano impegnati, spesso non lavorano a compiti che possano far progredire un progetto o un’iniziativa.
Non amano il loro lavoro. Il passivo-aggressivo non ama il suo lavoro. Potrebbe fantasticare di lasciare o addirittura sminuire il lavoro dell’azienda presso cui lavora. Ironicamente, la sua insicurezza spesso gli impedisce di cercare altre opportunità. Il paradosso del Passivo-Aggressivo è che quando viene avvicinato da un competitor, la risposta sarà molto probabilmente ‘no’. Il motivo è che il passivo-aggressivo spesso agisce secondo l’idea: ‘So cosa ho, non so cosa otterrò e le probabilità che possa essere peggio sono alte’.
Cercano altri odiatori. Il luogo comune “misery love company” è particolarmente applicabile ai passivo-aggressivi. Sono costantemente alla ricerca di altri colleghi che condividano le loro lamentele, ma non sono disposti a trovare soluzioniche possano porre rimedio a ciò che percepiscono come ingiustizia o inefficacia.
Invece di unire le forze per migliorare l’esperienza lavorativa, il passivo-aggressivo recluta seguaci nella sua battaglia contro la comunità lavorativa.
Inoltre mostra una piccata propensione al vittimismo e a dare la colpa alle persone che gli ruotano intorno e che non sono utili ai suoi interessi.
Non amano le nuove idee. Poiché è insicuro, le nuove idee e conoscenze lo fanno sentire minacciato. Quando si trova di fronte a iniziative progressiste da parte di altri, cerca di capire come tali iniziative danneggerebbero il suo potere personale. L’argomentazione avanzata contro queste iniziative: “Ci abbiamo già provato prima, e non funziona’, oppure “Sembra a posto, anche se non è rilevante per me’”.
Questo tende a renderli poco propensi ad aiutare gli altri.
DOVE NASCE IL COMPORTAMENTO PASSIVO-AGGRESSIVO
Uno studio sulla rivista Behavioral Sciences sostiene che un individuo si comporta in modo passivo-aggressivo perché spesso non è socialmente accettabile usare un linguaggio apertamente aggressivo. Così sente di doversi esprimere indirettamente per non ferire gli altri. Lo stesso studio afferma che alcune persone sperimentano l’aggressività passiva in quanto parte della loro personalità.
Nella prima edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , l’aggressività passiva grave era in realtà categorizzata come un disturbo mentale: personalità passivo-dipendente. Ma nella comprensione moderna, ora è solo uno in un elenco di sintomi patologici di disturbi mentali.
Sebbene comprendere la potenziale causa non sia così facile, può aiutare a prendere le distanze dalla situazione negativa con tutte le conseguenze e la frustrazione che ne può derivare.
COME GESTIRE I COLLEGHI PASSIVO-AGGRESSIVI
CHIEDI CONTO DI AZIONI E PAROLE. Il modo migliore per gestire un collega passivo-aggressivo è chiedergli conto delle azioni e delle parole.
Spesso fanno deragliare i progetti di squadra a proprio vantaggio o informano il responsabile di aver completato attività che in realtà non hanno fatto. Se hanno detto di aver accettato di fare qualcosa ma così non è stato, richiamali all’ordine immediatamente. Se hanno detto una cosa a te e un’altra a qualcun altro, chiedi loro conto di questo.
ADOTTA UNA COMUNICAZIONE CHIARA. Ognuno ha il proprio stile comunicativo preferenziale ma a volte potrebbe non essere consapevole di come il suo comportamento fa sentire gli altri. Forse il sarcasmo è una parte importante del suo senso dell’umorismo, o ha imparato che affrontare i problemi personali in modo indiretto è il (suo) modo migliore per superarli.
Se qualcuno mostra un comportamento passivo-aggressivo, usare una comunicazione assertiva, chiara e diretta può aiutare ad affrontare la situazione. Sebbene la franchezza non sia il punto di forza di tutti, esprimere i sentimenti in modo assertivo potrebbe fermare il comportamento sul nascere. Se ti trovi in un contesto professionale, prova a gestire le comunicazioni per iscritto o a coinvolgere un testimone terzo imparziale. Questo può aiutare a documentare il comportamento del passivo-aggressivo nel caso in cui si ripresenti.
CREA UN AMBIENTE SICURO. A volte, si comunica in modo passivo-aggressivo per insicurezza o perché si va sulla difensiva. Per esempio, potrebbe essere capitato, in passato, di rispondere in modo irruento, e ora questa persona potrebbe non sentirsi sicura di poterti dire determinate cose in modo diretto. Ecco perché creare uno spazio sicuro, può migliorare la comprensione e creare fiducia.
UTILIZZA IL LINGUAGGIO CON ATTENZIONE. Una parola sbagliata può far peggiorare rapidamente una situazione. Per evitare conflitti, usa le parole con attenzione. Evita di accusare l’altra persona di essere passivo-aggressiva in modo diretto. Invece di dare la colpa a chi hai davanti, sii onesto su come le sue azioni o parole ti hanno fatto sentire.
Se vuoi comunicare i tuoi sentimenti a una persona passivo-aggressiva, cerca di evitare affermazioni come “Tu” che incolpano l’altro per quello che è successo. Prediligi la prima persona: “Ho sentito” o “Non capisco“.
Ricorda, lo scopo della discussione non è ferire i sentimenti o peggiorare la situazione. È arrivare a una comprensione reciproca e migliorare il modo in cui entrambi comunicate.
STABILISCI DEI LIMITI. Sebbene stabilire dei limiti sia una parte importante di una relazione sana, può essere difficile quando entrano in gioco dinamiche di potere. Se hai a che fare con un collega passivo-aggressivo, tieni conto che potrebbe trascurare sistematicamente di considerare i tuoi sentimenti. Definire degli standard di comunicazione può aiutarti a creare condizioni di parità ed evitare conflitti.
I limiti sani possono consistere nel dire all’altra persona di trattarti con più gentilezza o nel limitare il tempo che trascorri con lei.
MANTIENI LA CALMA. È facile cadere in una spirale quando il comportamento passivo-aggressivo influenza le tue emozioni. Ricevere commenti negativi e trattamenti ingiusti è frustrante e doloroso, soprattutto quando accade spesso o proviene da qualcuno a cui tieni[5].
Sfortunatamente, non sarai sempre in grado di cambiare il modo in cui gli altri ti trattano o di influenzare il loro comportamento. Dovrai fare un respiro profondo e concentrarti su come rispondi a un commento o a un’azione passivo-aggressiva senza peggiorarla.
Conclusioni
Avere a che fare con una persona dai tratti passivo-aggressivo, sul lavoro, può essere logorante. Ma identificarla ti fornisce un vantaggio utile a gestirla in modo sano e consapevole, evitando così che ti trascini in un gioco, il suo, di cui non condividi e riconosci le regole. Inevitabilmente a perdere!
BIBLIOGRAFIA
[1] https://military.id.me/news/passive-aggression-military/
[2] Long N., Whitson S. (2018). The Angry Smile: The New Psychological Study of Passive Aggressive Behavior at Home, in School, in Relationships, in the Workplace & Online. Hagerstown, MD: The LSCI Institute. Passive-Aggression in the Workplace | Psychology Today
[3] Timms, M. (2022). Blame Culture is Toxic. Here’s How to Stop It. Harvard Business Review. Blame Culture Is Toxic. Here’s How to Stop It. (hbr.org)
[4] Ni, P. (2020). 7 Signs of Gaslighting at the Workplace. Psychology Today. 7 Signs of Gaslighting at the Workplace | Psychology Today
[5] Brown, D. (2021). The Professional Way To Handle Apologies And Forgiveness. Forbes. The Professional Way To Handle Apologies And Forgiveness (forbes.com)