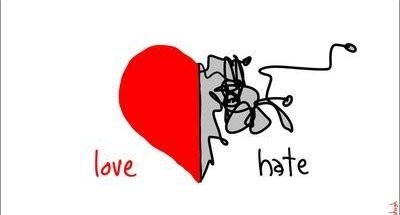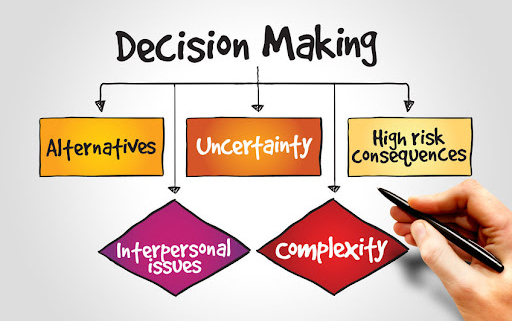SEI INCLUSIVO o stai facendo TOKENISMO?
Quante volte ci troviamo a fare concessioni simboliche per dare una parvenza di giustizia e inclusività? Per dimostrare di fare qualcosa che è visto come giusto e non perché crediamo davvero che sia la cosa giusta da fare?
Questo perché, probabilmente, siamo caduti nella trappola del #tokenismo, una forma di discriminazione subdola e pervasiva.
Entriamo nel merito.
COS’E’ IL TOKENISMO
Il fenomeno del tokenismo, o teoria della massa critica, è stato definito per la prima volta da Rosabeth Moss Kanter nel 1977. Secondo Kanter, è:
una pratica mediante la quale un gruppo di maggioranza accoglie una o più minoranze, al fine di sembrare inclusivo agli occhi degli altri.
Il tokenismo tocca ogni tipo di gruppo minoritario e si può trovare facilmente in diversi ambiti: dal mondo del lavoro alla televisione.
Non è un caso che negli ultimi anni – in particolare dopo il movimento femminista #metoo – sia facile trovare donne agli apici di aziende importanti. Tuttavia, il problema sorge dal momento in cui le donne presenti nelle aziende sono le uniche dell’intero ufficio, o quasi. Infatti, la presenza di una sola donna nell’intero team è un aspetto estremamente negativo: quella donna altro non è che un token: l’emblema della “donna forte e potente che può arrivare al vertice di una azienda”.
Agli occhi della società, l’azienda in questione diventerà simbolo di uguaglianza e apertura mentale, quando in realtà si tratta solo di tokenismo.
La vera inclusività sarà raggiunta solo quando il numero di donne aumenterà; lo stesso ragionamento è applicato al caso delle persone con disabilità all’interno dei board.
ESEMPI DI TOKENISMO
Dal 1991 esiste un termine che esprime perfettamente il concetto: the Smurfette Principle, “il Principio di Puffetta”: indica la presenza di una sola donna all’interno di un ampio gruppo di uomini, esattamente come nel cartone animato.
Il fenomeno del tokenismo è molto evidente in TV: è sempre più alto il numero di film e serie che raffigurano minoranze inserendo personaggi omosessuali, di colore, di religioni diverse e altre minoranze etniche, con il fine ultimo di dare una parvenza di inclusività, avendo, però, l’effetto opposto.
Questo perché i ruoli assegnati alle minoranze, rispecchiano gli stereotipi e i pregiudizi che solitamente vengono loro accomunati.
Inoltre, accade di rado che venga loro attribuita una parte di spessore, né, tantomeno, quella da protagonista. Anzi, spesso accade proprio che gli attori di colore ricoprano ruoli come l’antagonista della storia o personaggi con caratteristiche negative.
Ad oggi, tuttavia, si può parlare di sviluppi positivi in materia. I registi di film e serie tv recenti stanno iniziando ad applicare il colour-blind casting, al fine di scollegare la scelta dell’interprete da qualsiasi aspetto che riguardi il sesso biologico, l’identità di genere e l’etnia del personaggio.
L’attrice Jodie Turner-Smith nei panni di Anna Bolena, nell’omonima serie tv, è un caso emblematico; così come la maggior parte dei personaggi di Bridgerton: ad esempio, Golda Rosheveul, di origini guyane, interpreta la regina Carlotta e moglie di re Giorgio; mentre Regé-Jean Page, anglo zimbabwese, è il Duca di Hastings.
Un altro esempio è il personaggio di Token Black in South Park. In questo caso, la discriminazione non è reale, ma si inserisce nel solco satirico e parodiale del prodotto animato. Token Black rappresenta l’unico bambino afroamericano della serie (almeno fino alla stagione 16) ed è calamita di pregiudizi e stereotipi razziali da parte dei compagni di scuola. La sua fisiologica sensibilità alle critiche sociali, però, ha il merito di porre in risalto i contrasti e i preconcetti della società contemporanea, conducendo anche gli amici a riflettere sui problemi correlati alle questioni etniche e al razzismo (come nell’episodio “Le mie più sentite scuse a Jesse Jackson”, incentrato proprio sulle criticità della N-Word).
Il token è, quindi, un simbolo utilizzato per veicolare una parvenza di inclusività e atteggiamento paritario in un contesto, che attinge al bacino delle minoranze per creare una sorta di scudo nei confronti delle possibili accuse di discriminazione e apporre, un cerotto a un problema sistemico: il mancato coinvolgimento di tutte le fasce della società, dalle donne alle persone di colore, dagli individui con disabilità alle personalità queer.
Tradotto: tutti coloro che non sono uomini, bianchi, cisgender ed etero, ossia la norma.
GLI EFFETTI DEL TOKENISMO
Le conseguenze del tokenismo sono molteplici, e molti di noi, già le subiscono, pur non rendendosi conto dell’entità del fenomeno.
Il primo effetto è l’isolamento che l’individuo token percepisce nel contesto in cui è immerso. Con tutte le ripercussioni sulla salute che ne possono derivare.
Essere l’unica o una delle poche persone che condividono un’identità può sembrare isolante. Potrebbe non avere colleghi a cui rivolgersi per supporto e convalida quando si verificano aggressioni e attacchi. O, al contrario, il fenomeno può esporre a un’estrema visibilità, pensiamo alla pressione che vive l’unica persona di colore in un posto di lavoro o l’unica donna in una sala piena di uomini. Potrebbe essere tentata di lavorare troppo per cercare di essere un “buon” rappresentante di quel gruppo di identità, il che può portare a stress, senso di colpa, vergogna ed esaurimento. E a stati di frustrazione, depressione, rabbia e impotenza. Quasi come se la persona non avesse valore in sé, ma assumesse importanza solo perché portavoce di un gruppo di personalità escluse dai discorsi di potere e, per questo motivo, isolate.
PERCHE’ IL TOKENISMO è DANNOSO
A prima vista, il tokenismo potrebbe sembrare un impegno sincero per la diversità. Potrebbe, ma ci sono ragioni per non ricorrervi sui luoghi di lavoro (e non solo):
Morale e impegno dei dipendenti più bassi. Cosa pensi che accadrà quando i dipendenti tokenizzati si renderanno conto di non essere realmente apprezzati per i loro contributi, ma per la diversità che rappresentano?
Si demotiveranno. E questo può condurli a disimpegnarsi dal lavoro e ridurre la produttività.
Mina la fiducia e la credibilità. Se le persone capiscono che le iniziative per la diversità sono solo di facciata, si creerà un senso di sfiducia nei confronti del board. Questo le porterà a mettere in discussione ogni decisione. E quando la notizia di questa forma di discriminazione raggiungerà clienti, azionisti e partner, il danno di reputazione avrà conseguenze importanti sull’intera organizzazione.
Sopprime l’innovazione e la creatività. Il tokenismo riduce l’innovazione e il pensiero creativo. Quando non ci sentiamo presi sul serio, considerati, difficilmente siamo motivati dall’impegnarci e proporre soluzioni efficaci.
Aumenta i rischi legali e di conformità. Il tokenismo è una forma di disuguaglianza che a lungo andare può anche avere ricadute legali.
Danneggia la cultura organizzativa. La cultura organizzativa, in qualsiasi azienda, si basa sulla fiducia, sul rispetto e sull’inclusione autentica. Il tokenismo porta alla cultura tossica.
Crea un disallineamento con i valori aziendali. Il 63% delle aziende oggi si concentra sull’inclusione delle iniziative DEI nella propria visione, missione e valori. Tuttavia, l’esistenza stessa del tokenismo sul posto di lavoro evidenzia la differenza tra i valori dichiarati e le pratiche effettive.
Contrasto che può scoraggiare i dipendenti che potrebbero iniziare a riconsiderare la loro fedeltà e il loro impegno nei confronti dell’azienda.
SEGNALI DI ALLARME CHE INDICANO TOKENISMO SUL POSTO DI LAVORO
Minoranze in ruoli visibili ma senza potere. Il primo e più evidente segno di tokenismo si ha quando i collaboratori appartenenti a minoranze vengono inseriti in ruoli in cui sono molto visibili, ma non hanno alcun potere o influenza reale. Queste posizioni sono spesso simboliche, progettate per dare l’impressione di diversità senza dare l’autorità di apportare cambiamenti significativi.
In questo modo, si impedisce alle persone emarginate di acquisire l’esperienza e le competenze necessarie per ricoprire, in futuro, posizioni di leadership.
Mancanza di voci diverse nel processo decisionale. Non ha senso assumere persone rappresentanti minoranze se non vengono ascoltate. Dovrebbero avere la possibilità di parlare liberamente delle loro preoccupazioni.
I team con background diversi hanno maggiori probabilità di prendere in considerazione un’ampia gamma di prospettive e di prendere decisioni migliori e più informate, a vantaggio dell’intera organizzazione e non solo della maggioranza.
Turnover delle minoranze. Esaminando le statistiche di retention, ci si può facilmente rendere conto di quante persone appartenenti a gruppi sottorappresentati hanno lasciato l’azienda di recente. Se il tasso di turnover è alto, bisognerebbe cominciare a preoccuparsi. Quando le persone sentono di venir isolate, sottovalutate o minimizzate, è probabile che lascino l’organizzazione.
Il monitoraggio dei tassi di abbandono e la conduzione di colloqui di uscita possono aiutare a capire cosa le spinge ad andarsene.
Disparità di opportunità e responsabilità. Un altro segno di tokenismo si verifica quando le minoranze hanno titoli e ruoli che sembrano impressionanti, ma privi di responsabilità. Questo contrasto spesso significa che non ricevono le stesse opportunità di crescita e avanzamento dei loro colleghi. Non viene nemmeno offerta loro la possibilità di imparare e crescere.
COME PREVENIRE IL TOKENISMO
Il tokenismo non è sempre intenzionale. Ecco alcune strategie che possono tornare utili.
Concentrati sulla variazione del valore rispetto alle statistiche. Le statistiche danno una rapida panoramica di tutti i dati aziendali, ma non dicono come si sentono le persone o se ci sono preoccupazioni a cui rispondere.
Concentrarsi troppo sulle cifre può aiutare a raggiungere la quota di diversità, ma non porterà alcun cambiamento positivo nell’ambiente di lavoro. Meglio concentrarsi sugli sforzi di inclusione autentica per migliorare la cultura dell’ufficio. Ciò significa sviluppare politiche e pratiche che supportino il DEI nelle assunzioni, nelle promozioni e nelle interazioni quotidiane.
Benefit flessibili. Nel progettare i benefit, le aziende spesso tentano l’approccio “un pacchetto che va bene per tutti”. Questo porta a ignorare le esigenze della minoranza.
Se si desidera davvero offrire un trattamento equo a tutti, essere flessibili può essere di aiuto. Permettere alle persone di scegliere i propri incentivi dimostra che li si apprezza come persone e non solo come rappresentanti di un determinato gruppo.
Sviluppare processi di promozione trasparenti. A volte, le persone appartenenti a minoranze possono cadere nella trappola dell’impostore quando vengono promosse a posizioni di potere. Potrebbero mettere in dubbio le loro capacità e qualifiche. Promozioni basate sul merito, dove a tutti vengono offerte le stesse opportunità, indipendentemente dalla diversità in questione, possono aiutare a chiarire questi dubbi.
Seguire pratiche di assunzione inclusive. L’assunzione è il primo passo del percorso. Anzichè assumere solo persone appartenenti a un determinato gruppo sottorappresentato, è più funzionale creare job description che attirano organicamente candidati di diversa provenienza.
Quindi utilizzare panel eterogenei di valutazione per eliminare i pregiudizi, nonchè pubblicizzare le offerte di lavoro in luoghi che attireranno candidati qualificati, indipendentemente dalla loro situazione.