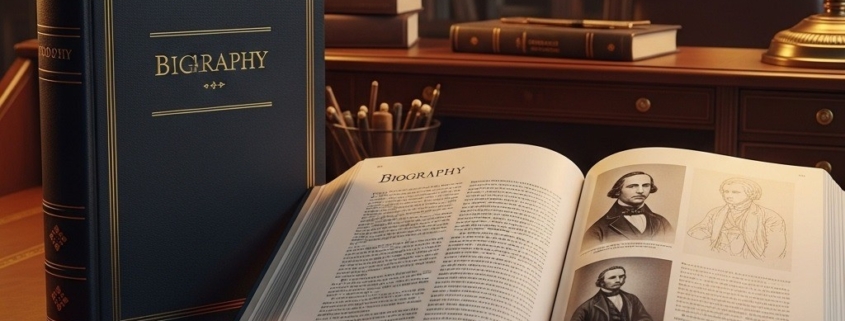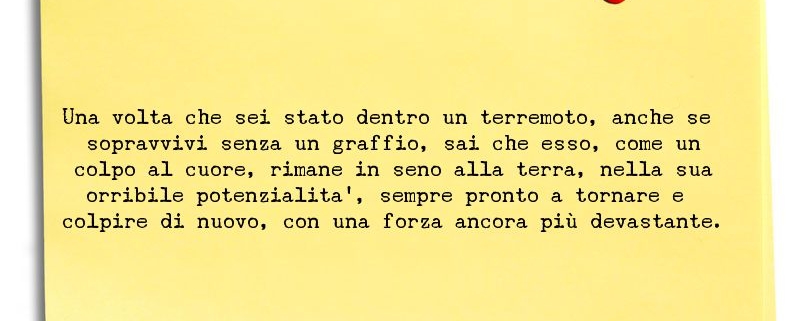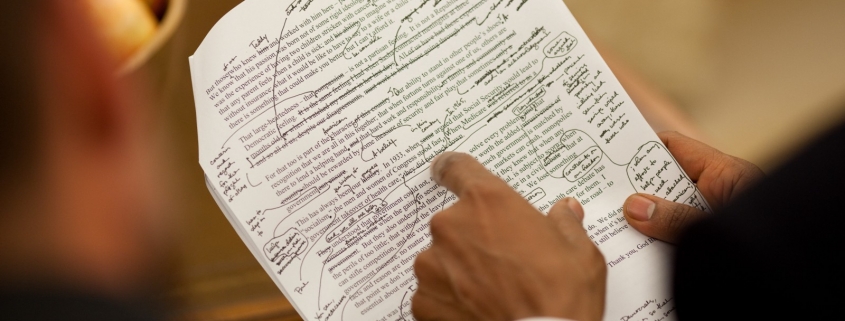La VANITA’ di RACCONTARE CHI siamo
Scrivere la propria autobiografia è difficile. Quasi sempre l’autore è troppo affezionato al protagonista. E non sempre, la vita che ha da raccontare, vale la pena di esser messa in pubblica piazza.
Anche scrivere il curriculum, presenta trappole insidiose. Per esempio, la vanità e la sintesi, sono spesso inversamente proporzionali.
Ne parlavo qualche giorno fa con un cliente, la difficoltà più grande è stata quella di convincerlo a inserire difficoltà e fallimenti nel CV. Reagan si presentava così: «Ronald Reagan è il presidente degli Stati Uniti». Il mio cliente non è presidente e salvo miracoli dubito possa diventarlo… (anche se forse lui questo non lo sa ancora)!
Più sei importante, meno hai bisogno di parole. Le biografie sono spesso un florilegio di titoli, cariche e opere che rivelano insicurezza. Qualunque essere umano, dopo i quarant’anni, è in grado di riempire una pagina o improvvisare un libercolo, al fine di soddisfare la propria latente vanità.
Una nota biografica non è un romanzo, è un riassunto. Cinque righe informano, venti annoiano, trenta allarmano, cinquanta generano sospetto.
Ci sono premi che non si devono vincere. Se accade, è bene mantenere riservata la notizia. Ce ne sono altri che è bello ottenere. In questo caso, la modestia ha il suo peso. Indicare un’onorificenza vale un’ammissione: «Per me è importante!»
Beneficenza e opere di carità sono parti intime: se non si vedono, è meglio. Frasi come «Il dottor S. ha condotto al successo molte imprese italiane e straniere» è pericolosamente vago. Di cosa si occupavano queste imprese? Mangimi, petrolio o affari internazionali? Dove operavano: in Cina o in Nuova Guinea? Evitare i superlativi e limitare gli aggettivi. «Marco V. ha ottenuto notevolissimi successi nel campo dell’informatica» lascia sospettare che sia riuscito, tutt’al più, ad aggiustare la Playstation del figlio.
Aggiornare periodicamente la fotografia. Ci sono colleghi che usano lo stesso ritratto scattato ai tempi del governo Andreotti. Quando v’incontrano, dovete sentirvi dire «lei sembra più giovane di persona!» e non «scusi, ma noi avevamo invitato suo figlio».
«Appare regolarmente in tv»: più che un titolo di merito, è un segno di disperazione. «Già presidente…»: più che un’informazione, è un rimpianto. «Ex deputato…» invece va bene: basta indicare anche l’ammontare del vitalizio.
Concedere qualche informazione personale si può: ma senza esagerare. Il nome della moglie va bene. Quello di tutti gli animali domestici, no.
Dimenticavo: alcuni di questi peccati li ho commessi. Questo decalogo vale come confessione e, spero, anche assoluzione…