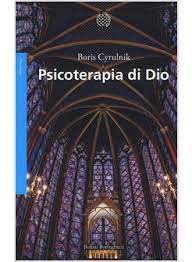UN UOMO MISTERIOSO, UN PO’ DIO, UN PO’ MEFISTOFELE…
Un uomo, in un bar, ogni giorno. Seduto in un angolo, con gli occhi tristi e stanchi. Un uomo senza nome, senza casa e senza sonno.
Un’agenda e tante persone addolorate, piegate, sconsolate che lo cercano e lui è lì per aiutarle. Purchè portino a termine compiti spietati, malvagi, crudeli.
UN UOMO MISTERIOSO, UN PO’ DEUS EX MACHINA, UN PO’ MEFISTOFELE
L’uomo è seduto a quel tavolo, e attende. Attende che i suoi “clienti” gli chiedano aiuto, si riflettano nel suo volto che è anche uno specchio oltre che rappresentazione di uno spietato deus ex machina del gioco al massacro, in cui o si scende a patti con la propria coscienza, con se stessi, con gli altri o ci si ribella alla richiesta, percorrendo un’altra strada.
Il viso dell’uomo senza nome porta con sé tutto il dolore, la stanchezza del mondo e, nonostante questo, assegna compiti infliggendo terribili condanne. Dando forma alle paure, alle ansie, alle angosce e ai desideri di tutti coloro che vogliono migliorare la propria vita, uscire dalla crisi, dal buio, ritrovare la propria strada, e forse finalmente essere felici.
Si entra in un castello kafkiano scuro e oscuro, stando accanto a quell’uomo che dà possibilità di vite alternative, come farebbe Dio, o forse Mefistofele (“Come faccio a sapere che lei non è il diavolo?“), in realtà però tutto e profondamente umano.
Così si accomodano a quel tavolo, per la “partita a scacchi” della vita, un poliziotto in lotta con se stesso e con il figlio; una suora che non sente più la voce di Dio e la ricerca con immensa sofferenza; un giovane cieco che ha un solo desiderio, vedere di nuovo; un padre che vuole salvare il proprio bimbo dal cancro; un meccanico che sogna di passare la notte con la donna da calendario. Il deus pagano ascolta e mostra a ciascuno la strada per raggiungere la propria felicità – che vuol dire danneggiare quella degli altri – e emerge chiaramente una domanda: cosa si è disposti a fare per avere ciò che si desidera?
The Place è tutto questo e molto di più. Un film che chiede allo spettatore di essere o dentro o fuori: se si sceglie la prima via si partecipa, scendendo in un inferno in terra, alle vite di questi uomini e donne afflitti e segnati, di essere partecipe della cognizione del dolore.
Non mostra mai tutto, fa immaginare, mette nella condizione di cercare le risposte (Cosa avremmo fatto noi al posto loro?), eviscerare il dentro per portarlo fuori, lega i personaggi del film in maniera sadica, spaventosa e machiavellica. Questi uomini e queste donne incredibilmente si incrociano in maniera crudele senza sapere però gli uni delle altre e il corso della vita dei primi in qualche modo condiziona quello delle seconde.
Violentare una donna, far scoppiare una bomba, insabbiare una denuncia di violenza; un Dio buono e giusto non chiederebbe mai nulla di tutto ciò, ma qui colui che offre la felicità è il più disgraziato di tutti, il più dannato, il più errato tra gli errati. Un “dio” fuori dagli schemi che forse dio non è, la cameriera Angela, pura luce, rispetto al buio di The Place, gli chiede se fa lo psicologo…
Ma lui non può tutto (“non ho tutto sotto controllo, le cose non dipendono da me”), non può indicare l’alternativa giusta, non tira i fili né scioglie i nodi di giorni imperfetti, l’uomo ha ideato il meccanismo ma poi a ciascuno dei questuanti spetta l’ultima parola. Non ci sono obblighi, c’è la possibilità di “rescissione del contratto”.
The Place è un film sul libero arbitrio, arma potente nelle mani dell’uomo, ciò che lo rende “l’essere” che è, è un film sull’affermazione di sé.
THE PLACE: IL RACCONTO DEL MALE NASCOSTO DENTRO DI NOI
Camminano paralleli e convivono, il bene e il male. Declinabili in tutte le loro sfumature, spietatezza e amorevolezza, amore e morte. Come in un girone dantesco lo spettatore si trova in mezzo alla sofferenza che il protagonista tocca con mano, assorbendone la portata devastante.
The Place non giudica, non sentenzia, strappa i panni di dosso e costringe a guardarsi dentro, racconta di chi deve anche commettere uno sbaglio per vivere meglio. Si tratta quindi, fino ad un certo punto, di vedere e parlare con il proprio lato oscuro.
Alla fine l’uomo senza nome è stremato, parlano i segni d’espressione, le occhiaie profonde, i gesti limitati dalla mancanza di movimento – c’è un’unità di luogo talmente radicata da provocare un senso di claustrofobia.
Crolla per umanità e a farlo cadere è Angela, nomen omen; l’unica a domandare, insistere, vuole sapere chi è lui, vuole farlo sorridere, lo guarda da lontano, lo osserva come si fa con i misteri e solo alla fine arriva al suo intento. Lei riesce a entrare nel suo mondo, è la (sua) coscienza che gli permette di vivere un attimo di pace, lo rende “debole” e così lui esce dal suo “personaggio”, si apre a qualcuno e si alza dalla sedia.
Tanto il senza nome è misterioso tanto lo è Angela, delicata e calma, sicura e potente, affascinante e disarmante; il Titano infatti timidamente sorride e metaforicamente se ne va (l’indomani mattina il bar è vuoto) lasciando dietro di sé un portacenere in cui c’è l’ennesimo, forse l’ultimo, foglio di carta (testimonianza dei compiti portati a termine) bruciato.
The Place è un film sul malvagio che c’è in ciascuno di noi ma è anche un film sulla speranza, nascosta dietro a un incontro semplice e banale. Questo è un quadro doloroso, nero, claustrofobico, è un urlo silenzioso, lunghissimo e straziante, è il racconto di un uomo che non è un mostro ma che dà da mangiare a molti mostri.
Ed è assolutamente da vedere…