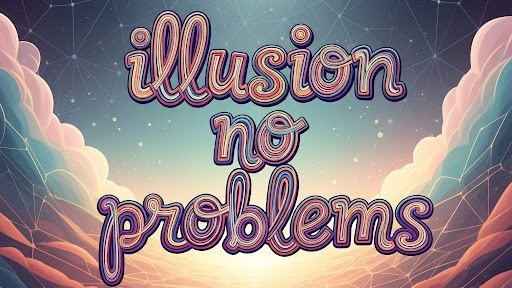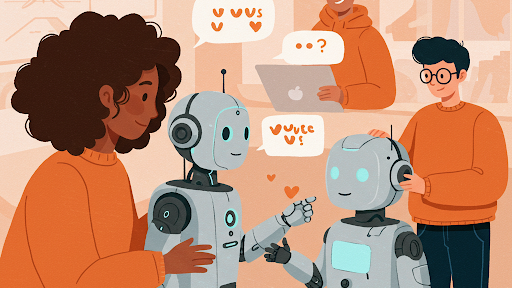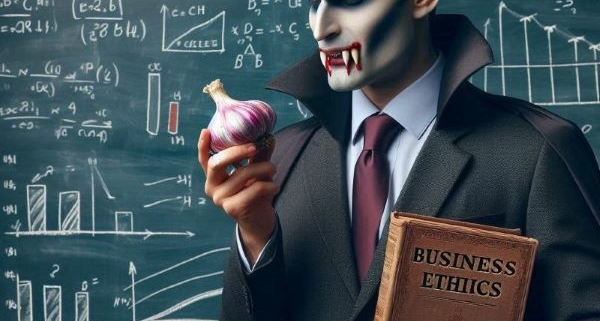Geoff Farrar aveva 69 anni quando è stato ucciso a martellate dall’amico Dave DiPaolo: compagno di scalate che aveva preso sotto la sua ala quando era ancora adolescente, quasi vent’anni prima, insegnandogli i segreti dell’arrampicata.
C’era, fra i due, un rapporto solido, come quello che normalmente si instaura fra mentore e protetto. Almeno fino a quando Dave non ha ucciso Geoff con un martello a uncino ai piedi di Carderock Recreation, nel Maryland.
Perché?
Cosa è scattato nella testa di Dave per portarlo a commettere un atto tanto violento nei confronti di un amico?
Per quanto sia difficile da accettare “chiunque può perdere la testa all’improvviso e venir assalito da una violenta rabbia omicida”, ha spiegato in relazione a questo episodio lo psicologo forense dell’università dell’Alaska, Bruno Kappes.
Il fatto è che la rabbia può esplodere senza preavviso, soverchiando il giudizio, la compassione, la paura e il dolore. E questo può spiegare, i tanti morti di omicidio e in parte anche perché le persone hanno molte più probabilità di essere uccise da un amico o un conoscente che da uno sconosciuto.
Le emozioni potenti come la rabbia e la paura possono farci sentire forti in una crisi o in una situazione conflittuale. Possono dare a una donna minuta la forza di spostare un’auto e liberare un bambino intrappolato o spingere un soldato contro il normale istinto di scappare, sotto una grandinata di proiettili per salvare un compagno in pericolo.
Un tale circuito cerebrale a risposta rapida ha senza dubbio giocato un ruolo quando il sergente maggiore dell’aeronautica militare statunitense Spencer Stone e due amici hanno immobilizzato un altro passeggero del treno, un terrorista armato di AK-47 e coltello, in Francia qualche anno fa: “Non è stata una decisione consapevole, ho agito e basta. È stato automatico“.
Questa stessa risposta automatica salvavita però può fallire e portare a una tragedia inaspettata e non solo ad atti eroici.
I FATTI
Gli eventi che hanno condotto all’omicidio di Farrar si sono svolti gradualmente. All’inizio, le evidenze raccolte suggerivano che Farrar fosse morto in un incidente di arrampicata. Presto, però, si insinuò il sospetto che DiPaolo, che era improvvisamente scomparso dalla zona e che quel giorno stava scalando anche lui, fosse in qualche modo responsabile.
Quando la polizia lo fermò, due settimane dopo, a Glens Falls – New York, DiPaolo dichiarò di essersi trattato di legittima difesa: Farrar lo aveva aggredito e mentre lottavano a terra, aveva afferrato un martello che si trovava sul sentiero e lo aveva usato per allentare la presa di Farrar.
Questa versione però non era convincente.
Trovare un martello sul sentiero sembrava improbabile, inoltre era difficile credere che un uomo giovane e in forma avrebbe dovuto usare una forza così brutale per respingere un 69enne. Le prove latitavano e questo alimentò pregiudizi e illazioni. Tanti si chiedevano se si fosse trattato di omicidio o di legittima difesa…
Geoff, quando venne trovato, era irriconoscibile. Non aveva più la testa, solo una massa viola sanguinante. Il primo colpo, venne poi accertato, è arrivato da dietro, un secondo alla tempia destra, quindi, a sinistra dove l’osso orbitale è stato frantumato spingendo l’occhio fuori dall’orbita, oltre alla frattura della mascella. E, in prossimità del corpo, in una buca poco profonda sul bordo del sentiero, una pietra insanguinata.
È bastato poco per capire che la legittima difesa qui non centrava nulla. E non si era nemmeno di fronte a un incidente di arrampicata, data la posizione del corpo rispetto al percorso, poiché la vittima non presentava abrasioni su gambe e braccia, come quelle che avrebbe riportato uno scalatore in caso di caduta.
“È stato attaccato in modo molto selvaggio. L’intera faccenda è durata meno di tre minuti.”
Intorno alla comunità di scalatori e amici, le illazioni continuarono: c’era chi considerava DiPaolo pazzo, chi esaurito, chi dipendente da sostanze. Poiché nessuno lo aveva mai ritenuto capace di fare male a qualcuno. Non così almeno.
Ci vollero due anni prima di arrivare a una risposta.
DiPaolo alla fine accettò un patteggiamento piuttosto che affrontare il processo, firmando una confessione in cui ammetteva di aver ucciso Farrar in un impeto di rabbia. Il 18 luglio 2016, DiPaolo fu condannato a 10 anni di carcere federale per omicidio colposo volontario.
LA VIOLENZA IMPULSIVA
Cosa è stato a scatenare tale violenza?
Questa reazione è stata a lungo oggetto di studio da parte dei neuroscienziati. Per molti anni, i ricercatori hanno postulato che questo tipo di aggressione fosse basato su una regione del cervello chiamata amigdala, che è associata alla paura, e con un livello di attività attenuato nella corteccia prefrontale, nota per le sue funzioni cognitive e il ruolo nel comportamento razionale.
La ricerca ha dimostrato, ad esempio, che i ragazzi aggressivi tendono ad avere un alto livello di attività nell’amigdala e un corrispondente basso livello di attività nella corteccia prefrontale.
Più di recente, le neuroscienze hanno identificato i circuiti neurali dell’ipotalamo associati a pulsioni come sete, fame e sesso, più capaci nel rispondere con velocità e impulsività a diversi tipi di minacce e provocazioni.
Questi circuiti di aggressività fanno parte del meccanismo di rilevamento delle minacce del cervello (situazioni che il cervello decreta tali), incastonato in profondità nell’ipotalamo. Negli esperimenti, quando i neuroni siti nell’ipotalamo ventromediale vengono stimolati da un elettrodo, un animale si lancia in un violento attacco e uccide un altro animale nella sua gabbia. Se la regione viene disattivata, l’aggressività diminuisce bruscamente.
C’è un contesto evolutivo per tali influenze biologiche. L’aggressività improvvisa, a volte definita risposta di lotta o fuga, è vitale per la sopravvivenza, ma non è esente da rischi. Per questo motivo, solo pochi specifici fattori scatenanti attiveranno i circuiti della rabbia del cervello verso l’aggressività improvvisa; ma una volta innescati, la reazione può essere incredibilmente forte.
“Stavo per soccombere. È stata una lotta estrema per la sopravvivenza“, ha spiegato Stone, il sergente maggiore dell’aeronautica. “Ero disposto a ucciderlo perché lui era disposto a uccidere me. Stava ovviamente cercando di spararmi e mi ha tagliato la gola con il coltello, quindi è diventato… non barbaro, ma avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per cercare di fermarlo“.
LE RADICI DELLA VIOLENZA
In una specie sociale, il successo di un individuo e l’accesso alle risorse dipendono dal suo rango all’interno della società. L’aggressività, soprattutto tra i maschi, è spesso il modo in cui si stabilisce il predominio nel mondo animale. Gli esseri umani hanno il linguaggio che può rapidamente trasformarsi in violenza esplosiva. “La polizia sta cercando un movente…” sentiamo spesso dire, ma è una ricerca vana. Questo tipo di violenza non è guidata dalla ragione. È guidata dalla rabbia.
Ciò che manca negli sconcertanti resoconti giornalistici di chi improvvisamente scatta violentemente è la storia di stress cronici pregressi sull’individuo, responsabili di innescare questi circuiti.
Prima dell’omicidio, DiPaolo era già considerato una sorta di emarginato, evitato per la sua incoscienza, i modi e gli atteggiamenti sciatti e da drogato. Il suo ex compagno di scalata, Matt Kull, ha detto alla rivista Outside di aver interrotto l’amicizia a causa dell’uso di droghe da parte di DiPaolo durante l’arrampicata e del suo crescente disprezzo per la sicurezza sua e degli altri scalatori.
DiPaolo aveva preso a vivere da solo e dormire in auto. Farrar aveva inoltre preso l’abitudine di criticare pubblicamente i fallimenti dell’amico. Lo status di DiPaolo nella comunità degli scalatori era in caduta libera.
Guardando indietro, possiamo identificare molti degli elementi che potrebbero portare una persona, alle prese con la droga e altre vicissitudini, a scattare in preda alla rabbia. Come possiamo riconoscere gli elementi e le influenze che potrebbero portare una persona, come Stone, a incanalare la sua rabbiain un’azione positiva.
“Tutte queste cose erano in un certo senso dentro di me prima“, dice Stone. “Mia madre ha cresciuto me, mio fratello e mia sorella, da sola. Ci ha messo prima dei suoi desideri e bisogni. Ha fatto quello che doveva fare. Questo era in un certo senso innato in me. Mi piace aiutare le altre persone. Ci tengo… quasi fino all’eccesso“.
Otto settimane dopo il fatto del treno, Stone è stato quasi ucciso da un membro di una gang armato di coltello, all’uscita da un bar con gli amici a Sacramento, in California: “Ancora una volta mi sono messo di fronte alle altre persone che venivano minacciate“. Mentre si stava riprendendo dalle ferite da coltello, e stava imparando a convivere con la disabilità, non ha potuto non interrogarsi sui comportamenti messi in atto e quando gli è stato se in futuro avrebbe fatto scelte diverse, ha risposto: “No, reagirò allo stesso modo. È come sono“.
Riconoscere l’importanza della biologia nei nostri comportamenti, persino imparare da essi, contiene solo alcune delle risposte di cui abbiamo bisogno di fronte alla tragedia. Ma è comunque qualcosa da cui partire.