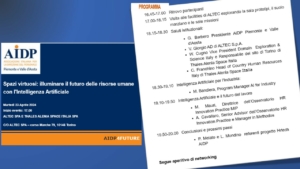SE ANCHE GLI INTELLIGENTI SI COMPORTANO DA STUDIPI…
Quanto l’intelligenza aiuta a prendere decisioni efficaci?
Meno di quello che si creda.
L’intelligenza è un tratto particolarmente apprezzato e spesso invidiato. Eppure, un quoziente intellettivo elevato non garantisce decisioni altrettanto razionali.
Steve Jobs, intelligente lo era senza alcun dubbio, eppure decise di curare il cancro con rimedi naturali anziché farmaci. E sappiamo come è finita.
Non meno immuni alcuni premi Nobel. Kary Mullis ha inventato il processo noto come reazione a catena della polimerasi (PCR), in cui una piccola porzione di DNA può essere copiata in grandi quantità in un breve periodo di tempo. Scoperta essenziale per la ricerca genetica. Però poi si è dichiarato scettico sui cambiamenti climatici e negazionista sull’Aids.
James Watson, uno degli scopritori del DNA, non ha risparmiato dichiarazioni in cui denigrava persone di colore, donne e minoranze[1].
Così come non sono pochi i fisici, medici, ingegneri, biologi, chimici, psicologi che negano teorie supportate scientificamente a vantaggio di credenze irrazionali.
In qualche modo è come se la posizione ottenuta da precedenti scoperte o successi, metta queste persone nella condizione tale da poter o dover dire ciò che passa loro per la testa (sarebbe più corretto dire per la pancia).
Perché accade questo?
In primis i test di intelligenza non misurano la capacità di fare scelte ponderate e informate. La razionalità è limitata e quando decidiamo e giudichiamo, ricorriamo a euristiche e siamo vittime di bias che puntualmente ci fanno sbagliare, come ha dimostrato Daniel Kahneman che per queste scoperte ha ottenuto il Nobel per l’economia.
Le persone che sbagliano nel prendere decisioni spesso si affidano troppo al pensiero intuitivo, evolutivamente antico e che funziona in modo automatico (Sistema 1) e molto meno a quello ragionato, lento e che processa informazioni basandosi sui dati (Sistema 2).
DISRAZIONALITA’
La razionalità è qualcosa di diverso dall’intelligenza. A dimostrarlo Keith Stanovich, scienziato cognitivo all’Università di Toronto, in Canada, che ha chiamato la discrepanza tra intelligenza e razionalità: disrazionalità.
Ha anche dimostrato che gli studenti più intelligenti, tendono a essere maggiormente vittime dei bias in quanto sopravalutano le loro capacità. Come è arrivato a questo risultato? Costruendo un modello dove, accanto al pensiero intuitivo, il Sistema 1, funzionano due sottosistemi del Sistema 2: la mente algoritmica e la mente riflessiva.
– L’intelligenza è il risultato dell’attività della mente algoritmica.
– La razionalità si ha quando la mente riflessiva riesce ad attivare la mente algoritmica e scavalcare o disabilitare la mente autonoma.
Il comportamento irrazionale è conseguenza del fallimento del processo di scavalcamento dovuto, fra le altre cose, a mancanza di conoscenze, nozioni male apprese e pregiudizi.
Le persone che usano la mente riflessiva nel problem solving, quando cioè devono processare informazioni che richiedono tempi di risposta lunghi, mediamente fanno pochi errori, mentre le persone impulsive hanno tempi di risposta brevi e come risultato incappano in numerosi bias.
A differenza di quanto si pensi, non è sufficiente l’introspezione per mitigare bias e pregiudizi. In un sondaggio sulle convinzioni pseudoscientifiche condotto sui soci del Club Mensa[2], in Canada, costituito da persone con elevato QI (nel 2% più alto), ha mostrato che il 44% credeva nell’astrologia, il 51% nei bioritmi e il 56% negli extraterrestri.
PARADOSSO DI SALOMONE
Re Salomone governò Israele circa 3000 anni fa, ed era famoso in tutto il Medio Oriente per la saggezza dei consigli che elargiva. Eppure, quando si trattava di prendere decisioni per sé stesso, si dimostrava molto meno astuto: aveva centinaia di mogli e concubine pagane, andando contro i precetti della sua religione, e non riuscì a istruire l’unico figlio, che crebbe fino a diventare un tiranno incompetente, e che alla fine contribuì alla caduta del regno.
Ecco, dunque, un altro esempio di come persone intelligenti agiscono stupidamente. E come sia più facile essere saggi e ponderati con i dilemmi altrui che con i propri. A darne evidenza, Igor Grossmann, psicologo all’Università di Waterloo, in Canada[3]. Insomma, quando si tratta di prendere decisioni per noi stessi, il nostro ragionamento si fa fallace. Più di quando si tratta di decidere per gli altri.
SINDROME DA RIUNIONE AZIENDALE
A volte, le persone intelligenti possono agire in modo stupido a causa del contesto in cui si trovano. Ad esempio sul lavoro.
In un esperimento condotto nell’università Virginia Tech, sono stati consegnati dei problemi astratti da risolvere individualmente, via computer. Man mano che le informazioni venivano processate, sullo schermo comparivano i punteggi di ogni singola persona coinvolta, comparati a quelli del resto del gruppo. Il feedback ha avuto come conseguenza quella di paralizzare alcune persone, abbassando i loro punteggi rispetto a prestazioni misurate precedentemente in specifici test. Nonostante i quozienti intellettivi degli individui coinvolti nell’esperimento fossero paritetici, i partecipanti alla fine si sono distribuiti in due gruppi distinti[4].
Ciò che è emerso è che vantarsi del proprio status, può causare ansia negli altri, spingendoli verso prestazioni inferiori. Non sempre la competizione spinge le persone a fare meglio.
Effetti simili si riscontrano nei team che, per risolvere un compito, ricorrono all’intelligenza collettiva. Se nel gruppo ci sono due o più membri eccessivamente zelanti che dominano la conversazione, anche se intelligenti e capaci, potrebbero portare a risultati inferiori rispetto ai team dove ogni individuo ha la possibilità di contribuire allo stesso modo.
In questi casi, le dinamiche personali contano di più del QI medio del gruppo nel determinare la performance del team. Questo perché un piccolo numero di persone non considera (o non si cura) che questo comportamento annulla l’intelligenza di coloro che li circonda[5].
Insomma, l’intelligenza è solo parte della storia, poiché da qualsiasi prospettiva la si guardi, abbiamo la prova che la razionalità, nel tempo e nelle persone, non è aumentata.
Fonti
[1] https://www.statnews.com/2019/01/03/where-james-watsons-racial-attitudes-came-from/
[3] Grossmann I., Kross E., Exploring Solomon’s paradox: self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults, Psychol Sci., 2014 Aug;25(8):1571-80.
[4] Kishida K.T., Yang D., Quartz K.H., Quartz S.R., Montague P.R., Implicit signals in small group settings and their impact on the expression of cognitive capacity and associated brain responses, Philos Trans R. Soc, Lond B Biol Science, 2012 Mar 5; 367(1589): 704–716.
[5] Woolley A.W., Chabris C.F., Pentland A., Hashmi N., Malone T.W., Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, Science, 29 Oct 2010, Vol. 330, Issue 6004, pp. 686-688