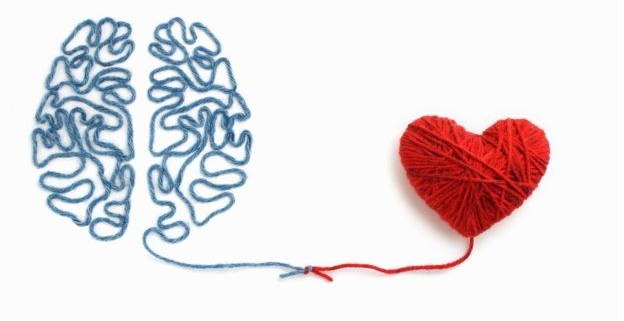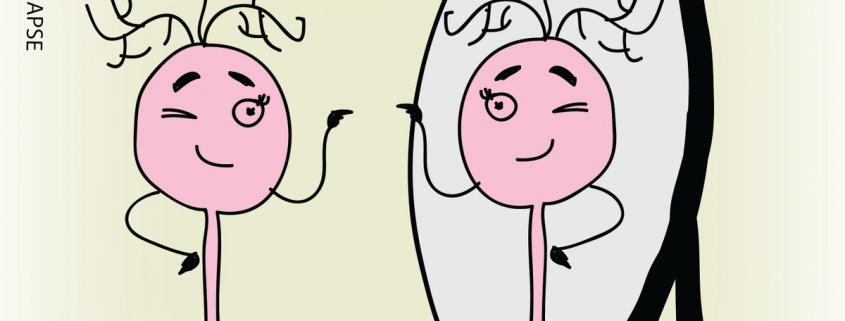La disonestà è un profumo nuovo appena acquistato. Le prime volte che lo applichi avverti per intero l’intensità della sua essenza. Man mano che i mesi passano lo percepisci sempre meno e per sentirlo sei costretto ad aumentare la dose che metti addosso, con il rischio di eccedere in modo sproporzionato.
Con la disonestà avviene lo stesso, come ci dicono le Neuroscienze.
In un esperimento condotto da Dan Ariely e pubblicato su Nature Neuroscience, a 80 persone è stata data l’opportunità di mentire ancora e ancora su un compito finanziario al fine di guadagnare denaro a spese di un’altra persona. Si è così scoperto che le persone iniziavano con piccole bugie, ma lentamente, nel corso dell’esperimento, mentivano sempre di più.
Al di fuori del laboratorio, ci sono molte ragioni per cui la disonestà può intensificarsi – gli incentivi potrebbero aumentare o potrebbe essere necessario nascondere bugie pregresse. Esaminare l’attività cerebrale delle persone mentre commettono atti disonesti ha rivelato un processo biologico chiamato adattamento emotivo.
COSA HANNO A CHE FARE LE EMOZIONI CON LA DISONESTA’?
La brutta sensazione che proviamo quando pensiamo di barare, spesso ci impedisce di mettere in atto l’intenzione. In sua assenza, si hanno maggiori probabilità di mentire. In uno studio, a un gruppo di studenti sono state somministrate delle sostanze beta-bloccanti in pillole che hanno ridotto l’eccitazione emotiva poco prima di sostenere un esame. Questi studenti avevano il doppio delle probabilità di copiare all’esame rispetto coloro i quali avevano ricevuto un placebo.
L’esperimento ha mostrato che la rete emotiva del cervello risponde sempre meno a ogni ulteriore menzogna. Maggiore è il calo della sensibilità del cervello alla disonestà, più persone mentiranno la prossima volta che ne avranno la possibilità. In altre parole, le persone che si sono adattate alla propria disonestà si tratterranno meno dal dire bugie più grandi appena ce ne sarà l’occasione.
L’attività cerebrale non è semplicemente diminuita nel tempo. La riduzione della sensibilità era proporzionale alla menzogna.
Un modo semplice di pensare a questo processo è di confrontarlo con un profumo. Immagina di aver acquistato un nuovo profumo. Appena lo indossi, puoi rilevarne l’essenza, l’intensità, ma passati alcuni mesi difficilmente riesci a percepirlo come invece avveniva i primi tempi. Quindi inizi ad applicarlo in modo più libero, sconcertato dal fatto che nessuno siederà accanto a te sul treno o in metro… Questo accade perché i neuroni nel bulbo olfattivo si desensibilizzano al profumo.
La disonestà ripetuta è un po’ come un profumo che applichi ripetutamente. Inizialmente la risposta ai tuoi atti di disonestà è forte, ma con il tempo diminuisce. Come gli studenti che assumono i beta-bloccanti, la tua capacità di essere disonesto aumenta.
Questo può sembrare desolante. Tuttavia, i dati hanno anche rivelato un lato positivo della natura umana. I partecipanti avrebbero potuto imbrogliare molto di più, ma non lo hanno fatto. Anche quando imbrogliando avrebbero avvantaggiato loro stessi.
La disonestà e il comportamento non etico sono molto diffusi, lo sappiamo bene. La stima della disonestà solo negli Usa vale 1 trilione di dollari in tangenti, 270 miliardi persi a causa di entrate non dichiarate e $ 42 miliardi in taccheggio e furti da parte di dipendenti.
Un bel po’ di soldi se pensiamo che invece uno dei desideri che più esplicitano gli esseri umani è farsi percepire morali dagli altri.
In un sondaggio sul World News and World Report, di qualche anno fa, è stata posta la seguente domanda: “Chi pensi sia più probabile che arrivi in paradiso?” Secondo gli intervistati, l’allora presidente Bill Clinton aveva una probabilità del 52%; la star del basket Michael Jordan il 65%; e Madre Teresa il 79%.
Chi ha ottenuto il punteggio più alto? Chi ha votato se stesso: la maggior parte degli intervistati pensava di essere migliore di Madre Teresa per quanto riguarda la probabilità di salire in paradiso.
La ricerca sulla moralità mostra che abbiamo una visione eccessivamente ottimistica della nostra capacità di aderire agli standard etici. Crediamo di essere intrinsecamente più morali degli altri, che in futuro ci comporteremo in modo più etico degli altri e che le trasgressioni commesse da altri sono moralmente peggiori delle nostre.
PERCHE’ CI COMPORTIAMO IN MODO DISONESTO?
Un risultato della ricerca è che le persone si impegnano in comportamenti non etici ripetutamente nel tempo perché la memoria delle loro azioni disoneste viene offuscata nel tempo. Le persone hanno maggiori probabilità di dimenticare i dettagli dei propri atti non etici rispetto ad altri incidenti, inclusi eventi neutri, negativi o positivi, nonché le azioni non etiche degli altri.
Chiamiamo questa tendenza amnesia non etica: una menomazione che si verifica nel tempo nella nostra memoria per i dettagli del nostro comportamento non etico passato. Cioè, impegnarsi in comportamenti non etici produce veri e propri cambiamenti nel ricordo di un’esperienza nel tempo.
Il nostro desiderio di comportarci eticamente e di considerarci morali ci dà una forte motivazione a dimenticare i nostri misfatti. Sperimentando un’amnesia non etica, possiamo far fronte al disagio psicologico e al disagio che proviamo dopo esserci comportati in modo non etico.
UNA AMNESIA DA NON DIMENTICARE
Quando sperimentiamo un’amnesia non etica, le ricerche dimostrano che diventiamo più propensi a imbrogliare di nuovo.
In ulteriori studi è stato offerto a oltre 600 partecipanti l’opportunità di imbrogliare e dichiarare erroneamente le loro prestazioni per denaro extra. Pochi giorni dopo, è stata dato loro un’altra possibilità per farlo. Il tradimento iniziale ha provocato un’amnesia non etica, che ha guidato un comportamento disonesto aggiuntivo sul compito che i partecipanti hanno completato pochi giorni dopo.
Poiché spesso ci sentiamo in colpa e pieni di rimorso per il nostro comportamento non etico, potremmo aspettarci che queste emozioni negative ci impediscano di continuare ad agire in modo non etico. Non è così. La disonestà è un fenomeno diffuso e comune .
Che ci piaccia o no, siamo disonesti più di quanto ricordiamo e se non mettiamo consapevolezza e una giusta dose di autocritica l’unico risultato che otterremo è diventare via via più disonesti, dimenticandocene. Proprio come avviene con il nostro profumo preferito.