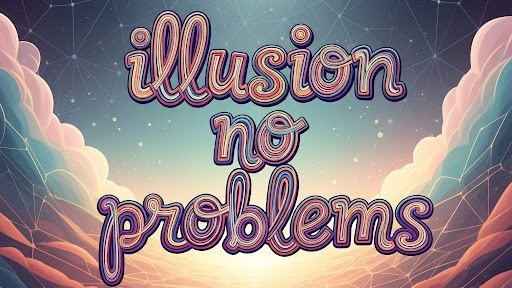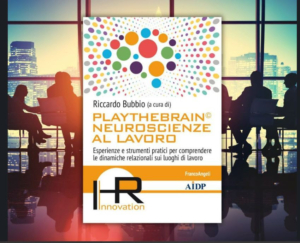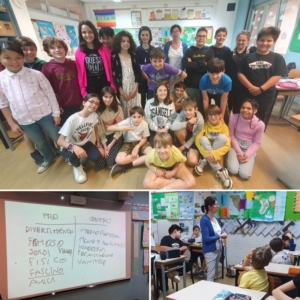Prendere decisioni semplici è un po’ come ordinare al ristorante: si valutano le opzioni disponibili e poi si sceglie quella che promette di offrire la massima gratificazione.
Quando si tratta di scelte complesse, come acquistare una casa, ideare un business plan o valutare le polizze assicurative, identificare oggettivamente l’opzione migliore è poco pratico e spesso impossibile.
La scelta di un piano di assicurazione sanitaria, ad esempio, richiede la stima della probabilità di aver bisogno o meno di una biopsia o di un’appendicectomia, un gioco di indovinelli a più livelli che sarà inevitabilmente pieno di errori.
La stessa cosa vale quando si deve scegliere una strategia di marketing: ogni potenziale mossa apre la porta a una miriade di reazioni da parte di clienti e competitors, portando a milioni di possibili scenari, ognuno dei quali il decisore può prevedere solo in modo imperfetto.
Quindi cosa occorre fare quando, in un processo decisionale, le alternative disponibili sono così complesse da non capire quanto valga ogni opzione?
A cercare di rispondere, i ricercatori della Kellogg School, avvalendosi di un laboratorio insolito: la scacchiera.
Utilizzando dati di 200 milioni di mosse da una piattaforma di scacchi online, i ricercatori sono arrivati a nuove conclusioni su come i giocatori trovano la loro strada attraverso la complessità.
Hanno scoperto che rallentare aiuta ma che i più bravi necessitano di molto più tempo decisionale extra rispetto i meno esperti. E contro intuitivamente che, aggiungere un’opzione mediocre, può essere peggio che aggiungerne una pessima.
Come i giocatori di scacchi prendono decisioni
Gli scacchi hanno diverse caratteristiche che li rendono perfetti per studiare le decisioni complesse.
La qualità di ogni mossa può essere classificata oggettivamente. A differenza di un piano assicurativo o di una strategia di marketing, dove misurare e classificare accuratamente ogni singola alternativa è raramente possibile, alcune mosse degli scacchi possono essere chiaramente identificate come parte di una strategia vincente: mosse che garantiranno una vittoria, indipendentemente da ciò che fa l’avversario. Allo stesso modo in caso si voglia un pareggio o una sconfitta.
Per quanto bizzarro, il gioco degli scacchi è riconducibile a mosse vincenti e non, predefinite, come dimostrato più di un secolo fa dal matematico tedesco Ernst Zermelo.
Eppure, nonostante ci sia la possibilità di valutare oggettivamente ogni mossa, la natura del gioco spesso rende difficile anche per i giocatori esperti distinguere una buona mossa da una cattiva. Di conseguenza, il modello standard del processo decisionale, in cui una persona valuta le opzioni una per una e poi seleziona l’alternativa migliore, in genere non si applica. L’enorme numero di mosse disponibili rende impossibile valutare ogni opzione (specialmente negli scacchi di velocità).
Pertanto, i giocatori in genere considerano solo un piccolo sottoinsieme di tutte le opzioni possibili e scelgono la prima che considerano abbastanza buona, cioè la prima mossa che credono produrrà una vittoria, una strategia che gli economisti chiamano “soddisfacente”.
Dato che molte decisioni del mondo reale richiedono anche un approccio soddisfacente, i ricercatori della Kellogg School hanno pensato che studiare come i giocatori si muovono sulla scacchiera, aiuti a capire meglio le dinamiche del processo decisionale complesso.
Un database monumentale di mosse scacchistiche
I dati presi in esame provengono da Lichess.org, uno dei più grandi server di scacchi online del mondo. Il database comprende otto anni di giochi, centinaia di milioni di mosse di centinaia di migliaia di giocatori (hobbisti e grandi maestri).
È importante sottolineare che i dati dicono non solo quale pezzo si è mosso e dove, ma la configurazione completa in ogni momento di gioco.
I ricercatori si sono concentrati su ciò che i giocatori chiamano “endgame”: scenari con un numero limitato di pezzi rimasti sulla scacchiera, e dove entrambi i giocatori stanno tentando lo scacco matto. In particolare, scenari con meno di sei pezzi sono stati utili perché sono stati “risolti” usando i computer, cioè per qualsiasi configurazione di sei pezzi sulla scacchiera, gli informatici hanno catalogato tutte le possibili mosse e come si inseriscono in una strategia che può garantire una vittoria, una sconfitta o un pareggio.
Ma ottenere i dati sulle mosse effettive è stato solo l’inizio. Per ogni finale, Salant e Spenkuch, questi i nomi dei due ricercatori, dovevano determinare tutte le possibili mosse che il giocatore avrebbe potuto fare, e se ognuna di queste era vincente, perdente o un pareggio.
Un lavoro di ricerca enorme, che ha richiesto 600.000 ore e dati contenenti 4,6 miliardi di ipotetiche mosse.
Chi prende la decisione giusta in situazioni complesse?
Gli studiosi hanno iniziato osservando come il grado di complessità influisse su quali opzioni venivano scelte.
Il modello economico standard di scelta prevede che le mosse vincenti più complesse (quelle che richiedono più passaggi intermedi per ottenere uno scacco matto) dovrebbero essere scelte più frequentemente rispetto alle mosse vincenti meno complesse. Salant e Spenkuch scoprirono che questo non era il caso negli scacchi: maggiore era la complessità di una mossa vincente, meno frequentemente veniva scelta, presumibilmente perché il percorso verso la vittoria era più confuso.
I ricercatori hanno scoperto poi che il livello di abilità di un giocatore influenza il processo decisionale: i migliori giocatori al mondo avevano meno probabilità dei meno esperti di commettere un errore. Divario che si è fatto via via più pronunciato con l’aumentare della complessità delle mosse vincenti, suggerendo che l’esperienza dei migliori giocatori li avvantaggiava maggiormente in scenari particolarmente difficili.
I livelli di abilità dei giocatori hanno anche influenzato il modo in cui si sono comportati sotto la pressione del tempo. Prevedibilmente, i giocatori titolati hanno commesso meno errori rispetto ai non professionisti, indipendentemente da quanto tempo è stato dato loro per scegliere le mosse.
Ma la differenza era minore nelle varietà più frenetiche di scacchi di velocità che si concludevano in pochi minuti. Nelle partite più lente, quando il tempo di decisione era meno limitato, i giocatori non professionisti erano considerevolmente più propensi a fare una mossa sbagliata. A beneficiare maggiormente del tempo, per pensare, sono i giocatori esperti.
Interessante è notare come i giocatori non sembravano in difficoltà di fronte al “sovraccarico di scelte” quando affrontavano un gran numero di mosse possibili: in realtà commettevano meno errori quando erano disponibili più mosse, probabilmente perché gran parte delle alternative in questi scenari erano mosse vincenti.
In pratica, per usare le parole dei ricercatori “Puoi aggiungere tutte le mosse vincenti che vuoi. Ciò non comporterà ulteriori errori. Se vuoi rendere il problema il più difficile possibile, devi aggiungere opzioni che non sono ottimali ma abbastanza vicine ad essere ottimali“.
Navigare nella complessità nel mondo reale
Per i ricercatori, “in ambito aziendale, è importante capire come le persone prendono decisioni a livello elementare“. Questo dice molto di come si approcceranno a quelle complesse. Ovviamente, il contesto lavorativo è più articolato di quello di un tavolo da gioco, a meno che ci si stia giocando i guadagni di una vita, o la vita stessa.
Tuttavia, ci sono lezioni che possono essere utili:
- I leader aziendali non dovrebbero presumere che un dipendente con le migliori prestazioni sceglierà l’opzione giusta in una crisi, in una frazione di secondo, ad esempio, poiché i dati degli scacchi suggeriscono che i benefici dell’esperienza svaniscono quando c’è scarsità di tempo.
- Non necessariamente una soluzione sarà quella scelta, senza contare che in questi casi, il paradosso delle scelte (troppe scelte, nessuna scelta), pare spingere a cercare la soluzione soddisfacente, anziché abbandonare il processo decisionale, come invece avviene nelle scelte semplici.
Forse queste ricerche ci aiuteranno meno di quello di cui avremmo bisogno di fronte a situazioni complesse, ma forse il bello della sfida è proprio questo: non c’è una soluzione preconfezionata. La possibilità di pensare. E al giorno d’oggi, non è poco.